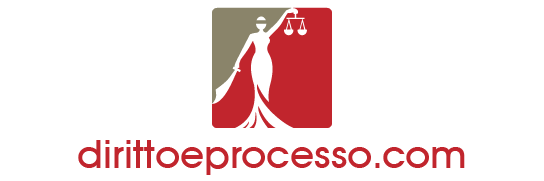RECESSO INDOTTO DAL DATORE DI LAVORO DI INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Ettore William Di Mauro
Il caso posto in esame tratta di un recesso “indotto” da parte del lavoratore che ha sottoscritto un contratto di incarico per prestazione professionale,
La domanda che si pone è capire chi è il giudice competente per l’insorgere della controversia e quali sono i mezzi giuridici da utilizzare.
Sulla competenza del giudice sembra doversi affermare quella del tribunale ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro in quanto l’art. 409 c.p.c. viene interpretato dalla giurisprudenza e dalla dottrina in modo estensivo[1]. Infatti secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione l’art. 409 si applica a controversie relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro ma anche quelle in cui la pretesa dedotta in giudizio si ricolleghi direttamente a tale lavoro nel senso che, pur non costituendo la causa petendi di tali pretese, si presenti come antecedente e presupposto necessario, non meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale[2].
In particolare al rito del lavoro sono soggette le pretese di carattere patrimoniale, sia quelle che, traendo origine dal rapporto di lavoro, hanno contenuto non patrimoniale (es. mansioni, libertà, dignità). Di conseguenza il lavoratore a tempo determinato (nel caso di specie) può chiedere il risarcimento dei danni per comportamento ingiurioso del proprio datore di lavoro e del superiore gerarchico[3] al giudice del lavoro.
Si è posto il problema se il presente contratto potesse essere ritenuto come lavoro autonomo anche per la presenza della P.Iva del professionista ed essendo stato richiesto dal datore di lavoro la particolare competenza tecnica dello stesso.
Tuttavia si è ritenuto che non potesse essere considerato tale per mancanza dei requisiti enucleati dall’art. 2222 c.c. (l’assenza di vincolo di subordinazione nei confronti del committente) in quanto dal contratto risulta che il professionista, nell’esecuzione di quanto oggetto del presente incarico, si troverà ad interagire con professionisti interni alla Società delegati a sovrintendere alla pratiche direttamente riconducibili ad interessi particolari della Società Committente.
Per quanto riguarda i mezzi giuridici sembra doversi orientare verso la sola possibilità di risarcimento del danno per dimissioni “indotte”(c.d. danno da dimissioni per giusta causa derivanti da mobbing).
In questa ipotesi si deve far riferimento all’art.2119 c.c. dove si prevede il risarcimento del danno patrimoniale pari ciò che il lavoratore avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto ed in più il danno morale(dolore, sofferenza dell’animo) e psichico (danno alla vita di relazione che si realizza ogni qualvolta il lavoratore viene aggredito nella sfera della dignità senza che tale aggressione offra sbocchi per altra qualificazione risarcitoria[4]). Quest’ultimo danno deve essere dimostrato attraverso la sua costanza nel tempo sia durante il rapporto di lavoro che dopo anche attraverso referto medico). Importante è la sentenza della cassazione n. 9539 dek 08 settembre1999 dove si ammettono danni conseguenti al risarcimento del danno biologico e alla vita di relazione, del danno all’immagine e al risarcimento dei danni morali conseguenti al demansionamento, alla richiesta di dimissioni, minacciando anche una denuncia per furto e per aver divulgato in azienda il contenuto delle contestazioni disciplinari e le motivazioni del licenziamento, con comportamento integrante ingiuria e diffamazione.
Il datore di lavoro può procedere al c.d. licenziamento disciplinare qualora ne ricorrano presupposti ma ha l’obbligo di esporre nel luogo di lavoro il c.d. codice disciplinare, deve contestare per iscritto gli addebiti specifici mossi al lavoratori e deve concedere un termine al lavoratore per consentirgli di spiegare le sue ragioni agli addebiti mossigli (art. 7 della legge n.300 del 1970 c.d. Statuto dei lavoratori).
La violenza morale esercitabile dal datore di lavoro, che può determinare l’annullabilità delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, può esprimersi secondo modalità variabili e indefinite anche non esplicite: può agire anche solo come concausa,ed essere ravvisata nella minaccia dell’esercizio di un diritto (Cass. N. 5154 del 26 maggio 1999). È possibile, dunque, anche l’annullamento delle dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento per giusta causa perché viziate da violenza morale solo qualora venga accertata l’inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento, non sussistendo l’inadempimento addebitato al dipendente, in quanto in questo caso con la minaccia del licenziamento il datore di lavoro persegue un effetto non raggiungibile con il legittimo esercizio del proprio diritto di recesso (Cass. N. 6577 del 26 aprile 2003).
Ai fini dell’annullabilità dell’atto di dimissioni ottenuto con la minaccia di licenziamento, vanno valutate, oltre all’obiettiva natura intimidatoria o meno dell’invito alle dimissioni, anche, in modo compiuto e approfondito, le modalità fattuali del comportamento tenuto dal datore di lavoro(cass. N. 12693 del 29 agosto 2002)
[1]V. codice di procedura civile commentato, artt, 287-632, diretto da C. Consolo, p. 1334 e ss.
[2]Cass. N.16865 del 28 novembre 2002, Cass. N. 4129 del 22 marzo del 2002, Cass n. 2450 del 20 febbraio 2001, cass n. 6916 del15 luglio 1998.
[3]Cass. N.9539 del 08 settembre 1999
[4]Trib. Forlì del 15 marzo 2001